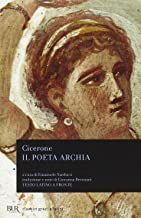
Nel 62 a. C. Marco Tullio Cicerone assunse la difesa di Licinio Archia, un poeta in lingua greca di origine asiatica che era accusato di aver usurpato la Cittadinanza Romana.
Archia aveva svolto, fin da giovanissimo, la professione di poeta e letterato al servizio di famiglie nobili, che gli avevano affidato la celebrazione delle gesta dei loro membri più in vista. La sua opera più conosciuta era un poema dedicato alla guerra contro Mitridate, nella quale, al fianco di Pompeo, si era distinto in gloriose vittorie il grande Lucio Lucullo, della gens che proteggeva Archia, cui fu tributato un solenne trionfo nel 63 a.C.
Un oscuro accusatore, dietro il quale forse si nascondeva una famiglia ostile ai Luculli, denunciò Archia evocando il sospetto che avesse violato la legge sulla Cittadinanza. Cicerone lo difese con impegno straordinario in aula, senza tuttavia far leva su argomenti tecnico-giuridici, in ragione dei quali la posizione di Archia avrebbe rischiato di rivelarsi piuttosto fragile. No. Forte del fatto che il presidente del Tribunale era il suo stesso fratello Quinto e che i potenti Metelli e Luculli che proteggevano Archia avrebbero esercitato forti pressioni per evitare una condanna, il grande oratore trascurò quasi del tutto la parte tecnica della prolusione per sviluppare un lungo, articolato, elegantissimo discorso che rimarrà immortale, sulla figura del poeta. Un discorso extra causam. Un discorso sull’importanza, il valore, il senso della cultura nella società umana. Un’intensa e appassionata apologia della cultura umanistica, della poesia, delle lettere, del ruolo che hanno nella costruzione di una società fondata sul valore della memoria, sull’esempio degli uomini più virtuosi, sull’etica pubblica.
Etica pubblica, sì, perché per Cicerone e i suoi contemporanei, la dimensione pubblica, il riflesso delle azioni del singolo sul bene comune, è quella più gloriosa e al tempo stesso più dignitosa, che possa toccare a un uomo di valore, a un Princeps civitatis. La poesia, le lettere, possono essere svago, lusus, distrazione dai negotia del quotidiano vivere. Rendono giustizia e immortalità al principe, all’uomo straordinario. Hanno carattere magico e sacro, divino, perché ammansiscono le bestie e fanno cantare le rocce del deserto. Sono fine diletto dell’anima nobile. Ma soprattutto sono lo strumento per offrire una dimensione di unità, grandezza e forza al Popolo Romano. Sono il contributo essenziale al consolidamento della Res Publica. Perché ogni attività del cittadino, e dunque anche del poeta, ha senso e valore solo se animata da un officium, da un intento di servire la dimensione pubblica, collettiva.
Catullo ascoltava, in silenzio, le parole di Cicerone, immagino con quale stato d’animo di assoluta distanza emotiva, ideologica, programmatica. Forse dentro di sé rideva di quella visione, sognando e credendo in un senso diverso per la Poesia, per quegli accenti così intimi, personali, privati, esclusivi, che sentiva muoversi dentro. E anch’io, oggi, posso sentirmi così, come al crepuscolo, più vicino al moderno Catullo e alla sua visione straordinariamente anticipatrice.
Sento però che quel marmo romano, candido e un po’ freddo come la virtù, accoglieva un’idea che fece grande e longeva quella Nazione: il mio contributo ha valore solo se sostiene lo sforzo e il nome onorato di tutti. Il nome di tutti, che dipende dall’onore di ognuno. Di quel senso arcaico, di quello spirito forsennato che animò un popolo per mille anni, qui, proprio nel luogo dove prese vita e fu incarnato, oggi non rimane che marmo annerito.
Il poeta Archia, Marco Tullio Cicerone, BUR